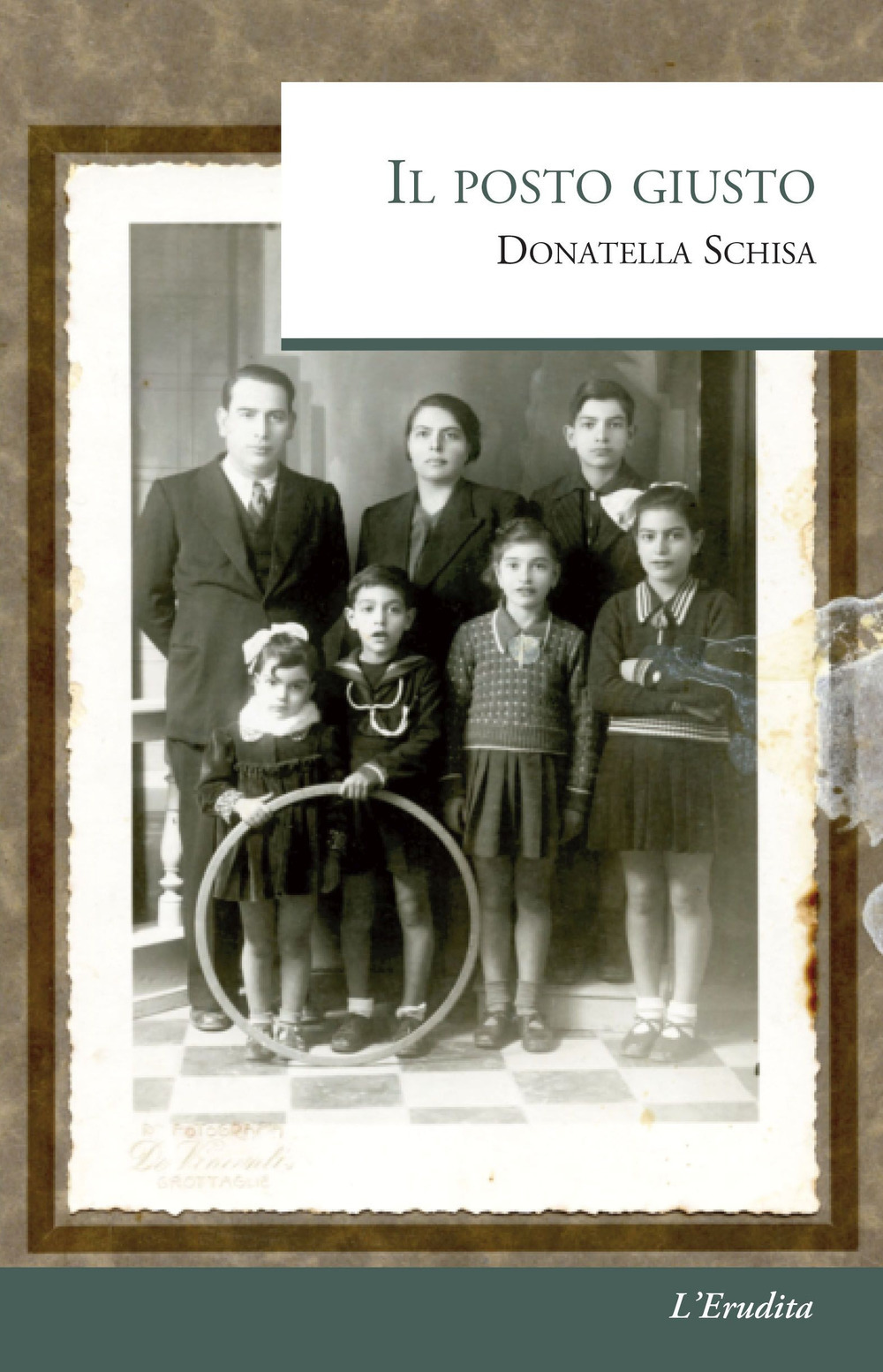Arrivo all’aeroporto di Napoli Capodichino in una giornata tiepida, ma velata. Sono qui per accogliere Lisa Ginzburg che arriva da Parigi per partecipare oggi a Strane coppie, ciclo di incontri letterari organizzati con cadenza mensile da Antonella Cilento.
Un pò mi spiace, avrei voluto che Napoli si mostrasse con il suo volto migliore, ma, quando atterra, Lisa è così contenta di essere qui, in Italia, da non farci nemmeno troppo caso. E allora ci dirigiamo a Piazza dei Martiri, luogo strategico per la vicinanza al suo albergo, e prendiamo posto nella saletta interna di una nota caffetteria per cominciare finalmente la nostra chiacchierata.
Buongiorno, Lisa, e grazie di essere qui con me oggi.
Le domande che vorrei rivolgerti sono tante, per cui non sarà semplice, ma da qualche parte si deve pur cominciare. E allora parto dalla tua penultima pubblicazione “Buongiorno mezzanotte, torno a casa”, uscita per Italo Svevo edizioni nel 2018.
Nel pamphlet, che si rifà nel titolo ai versi di Emily Dickinson, tu racconti il non ritorno, un tema che ti sta evidentemente molto a cuore.
Nel farlo, lo dico per quelli tra i nostri lettori che non lo avessero ancora letto, tu analizzi le biografie di alcuni scrittori, Anna Maria Ortese, Nikolaj Gogol, James Joyce, Jean Rhys, all’interno delle quali, pur nella loro diversità, rintracci un tratto comune, un filo rosso: l’esilio, declinato in tutte le forme possibili, distanza, distacco, straniamento, lontananza, deplacement e il desiderio di ritorno cui non si riesce a dar seguito.
Una vocazione all’altrove potremmo dire, dunque, un perenne stato di non conciliazione che risuona fortemente anche in te.
Vuoi parlarci di questo senso di sradicamento e dirci se tutto questo abbia in qualche modo a vedere anche con le tue radici ebraiche?
L’idea di vocazione all’altrove mi sembra bella e giusta per provare a descrivere questo genere di conflitto interiore che è continuo, nonostante il fatto che aver messo nero su bianco certe modalità mentali mi abbia aiutato quantomeno a governare meglio la situazione da un punto di vista psicologico.
Per descriverlo con parole mie faccio un esempio: sono appena atterrata in Italia, torno dopo cinquanta giorni (che per me sono tanti, perchè faccio in modo di venire spesso) e all’arrivo mi sono commossa.
Questa vocazione all’altrove significa probabilmente l’inverso, cioè che se mi trattenessi qui in Italia altri cinquanta giorni, scalpiterei per tornare in Francia o che se mi fermassi cinquanta giorni in un altro luogo, scalpiterei per andare via.
Questa è si un’inquietudine geografica, secondo me, ma anche uno stato di buona salute, nel senso che in tempi retrogradi e nazionalisti come gli attuali, in cui ognuno sta a casa sua con la sensazione che il mondo, anzichè ampliarsi, si stia rimpicciolendo, possedere una natura del genere è anche una virtù. Nei fatti comporta tuttavia un senso di non appartenenza, una sorta di smania, che ti porta a litigare interiormente col luogo dove sei, il che equivale a non star bene mai.
Tu ti sei occupata a lungo di filosofia, di mistica francese del seicento in particolare, e sei stata direttrice di cultura dell’Unione Latina. Come racconti nel tuo libro “Pura invenzione” hai trascorso molte delle tue giornate a Parigi, “intenta a sfogliare enormi infolio seicenteschi nel tentativo affannoso di cogliere il bandolo di un intricato groviglio”. Groviglio che ti sfuggiva continuamente dalle mani, fin quando un amico ti ha detto che il tuo problema era non aver trovato un tuo tema.
Fu quella un’epifania e racconti nel libro che un’involontaria contrazione all’altezza dello stomaco te ne diede immediata conferma.
Descrivi molto bene questo passaggio tormentoso che ti ha portato ad abbandonare la filosofia per la letteratura e che hai superato, scrivi, grazie a una citazione incontrata in uno dei taccuini di tua madre: “Nel mondo a venire, non mi si chiederà: “Perchè non sei stato come Abramo, perchè non sei diventato Mosè?” Mi si chiederà soltanto: “Sussja, perchè non sei stato Sussja?”
Vuoi dirci del momento in cui hai realizzato che avresti potuto essere te stessa solo inventando?
Io mi annoiavo molto in quei lunghi pomeriggi nelle biblioteche parigine e me ne accorgevo perchè la mente andava sempre altrove, c’era un’inquietudine, e nello stesso tempo un benefico elemento di rigore datomi da quegli studi così aridi, quelle dispute sottili, in cui non c’era uno straccio di cuore e le passioni erano solo teorizzate, sistematizzate. Tanto rigore mi sembrava fosse importante, perché io ho una natura che tende alla distrazione, a delle impennate, a un certo caos; hdunque, quelle sponde, che erano la filosofia e il pensiero rigoroso, mi sembravano utili per comprimere e dare forma a un materiale di vita interiore altrimenti incandescente e con elementi distruttivi.
Però a un certo punto questa aridità mi ha soffocato ed è sopravvenuta allora una rottura molto forte: avevo poco meno di 30 anni, ho chiuso una relazione che stava per diventare un matrimonio e negli stessi mesi ho cambiato attività, lasciando un postdottorato e iniziando a lavorare in una casa editrice in cui guadagnavo poco, ma ero più vicina alla letteratura. Così mi sono messa a scrivere. In realtà avevo sempre scritto, diari, racconti, però il coincidere di questi drammi scatenati da me stessa, di questi due abbandoni, mi ha dato finalmente un’autolegittimazione.
Per nessuno, secondo me, è facile darsi il diritto a scrivere; nel mio caso, quando si hanno in famiglia personalità importanti, famose, anche un po’ opprimenti, la posta in gioco è creare condizioni di crisi molto forti per poter cominciare. Dopodichè, la legittimazione è un qualcosa che va alimentato di continuo, perché c’è sempre una voce che va contro lo scrivere.
C’è un altro momento molto toccante, a mio avviso, di cui racconti in “Pura invenzione” e che riguarda il dubbio corrosivo che ti ha attraversato e che è emerso grazie all’analisi; il dubbio di non possedere una vera vocazione e di essere approdata alla scrittura perché con quella formazione e quel genere di famiglia alle spalle era scontato.
Tu scrivi che la svolta è arrivata quando hai opposto un secco no a chi ti suggeriva la strada della pseudonimia per ovviare all’ingombro del cognome.
E’ così? E’ lì che hai trovato la tua voce?
Non credo che l’aver trovato la mia voce abbia corrisposto in termini cronologici a quel no che dissi a due figure diverse, entrambe molto importanti, le quali mi suggerivano di usare uno pseudonimo. Ma certo rifiutarmi è stato aprire una strada, anche se trovare la propria voce a volte può essere immediato, altre può prendere moltissimo tempo, come nel mio caso. Una cosa che mi incoraggia è che noi stessi sappiamo bene quando una cosa vale o non vale, siamo buoni giudici dell’intonazione della nostra voce e lo sentiamo molto chiaramente quando qualcosa che scriviamo ha quella giusta. E quando non ce l’ha io soffro, è uno dei tormenti di questa attività meravigliosa, ma così faticosa in termini psicologici, perchè quando non sei contenta di quello che scrivi, è davvero una pena. Ti senti come uno che suoni e non riesca a intonare bene lo strumento, o come un chirurgo che usi male i ferri per operare. Devi sentire insomma una centratura, tutto deve tenersi compatto e, quando non è così, ci sono malumore e tormento.
Una volta assestati però, tu dici che occorre il riconoscimento della propria voce da parte di chi ci ha generato. A te la legittimazione materna non è mai mancata, tua madre ha creduto in te e nella tua scrittura fino a quando c’è stata, così come tua nonna, anche se è andata via presto.
Leggendoti, però, si ha l’impressione che ciò che ti è mancato, ma d’altronde tu lo scrivi, è il confronto con il fronte paterno.
Vuoi dirci di questo passaggio?
Non credo che ci siano storie di scrittori che hanno avuto un battesimo della loro vocazione da parte di entrambi i genitori. Penso che in genere ci sia un rapporto privilegiato con un genitore piuttosto che con un altro. Più che della persona fisica io parlo comunque in “Pura invenzione” di funzioni archetipali.
Dal punto di vista della creatività, penso che un padre che non approva il tuo lavoro ti mette in una condizione di orfanità, di mancanza, che ti costringe a dare a te stesso il tuo proprio valore. Nel mio caso, essendo io come ti dicevo qualcuno che ha bisogno di disciplina e rigore, il fatto che sia mancato questo appoggio proprio dal lato in cui in termini archetipici disciplina e rigore dovrebbero venire trasmessi, insegnati, il valore me lo sono attribuita da sola.
In questo sono contemporanea (ride): oggi si parla molto di funzioni paterne da reinventare. Nel mio romanzo “Per amore” definisco la protagonista “buona madre di se stessa”. Ecco, anche essere buoni padri di se stessi è importante e per una donna lo è moltissimo: integrare nella propria vita professionale (e non solo) un principio maschile di autocontenimento.
In “Buongiorno mezzanotte, torno a casa” tu racconti che sin da bambina dividevi gli esseri umani in due categorie, i casalinghi e i fuorilunghi, ed eri convinta di far parte dei primi, ritrovandoti poi, invece, a sorpresa, nella tua vita adulta, tra i secondi. E, pur essendo convinta che più interessante sia la categoria dell’errare, nella doppia accezione di “viaggiare” e “sbagliare”, dici di invidiare i primi, perchè, a tuo avviso, sta nella capacità di “fare casa” la salda maturità di una vita.
Tu, insomma, sei una creatura in transito, anche se il tuo è divenuto un transito duraturo.
Ti ritrovi nella definizione “creatura in transito”?
Ti faccio un esempio: oggi sono qui a Napoli per parlare all’interno della manifestazione “Strane coppie” di Antonella Cilento di “Piccole donne”, libro completamente attraversato da un’idea di miglioramento morale, un’idea anche un po’ all’antica e doveristica, se vuoi, secondo cui tutti noi veniamo al mondo anche per cambiare il nostro carattere e non solo per accettarci, benvolerci e dire: “sono fatto così”.
Io credo personalmente nel valore del provare a cambiare e vedo che, da quando ho passato i cinquant’anni, ci sono state delle metamorfosi in me. In fondo, dopo aver scritto “Buongiorno mezzanotte, torno a casa” questo anelito al radicamento sta diventando un’esigenza reale, amo meno di prima viaggiare e oggi ho una casa nuova in Italia, vicino alla campagna, dove cerco di passare più tempo possibile. Ho capito che, analogamente a quanto accadeva rispetto al rigore degli studi filosofici, autocontenermi nelle sponde di una vita un pò più sedentaria mi fa bene. Credo insomma nella sfida: se hai delle tendenze non devi solo assecondarle, perchè è molto importante anche quello che si sprigiona quando tu ti metti in condizioni opposte, meno facili.
Nel mio caso, dunque, “fare casa” è stata una conquista, un punto d’arrivo.
Allontanarsi, lasciare l’Italia per la Francia ha significato per te un tentativo di rinascita. Usare la geografia dei luoghi per porre rimedio alla tua storia in qualche modo, possiamo dirlo?
Più che parlare di rimedio, direi che per me sia diventata paradossalmente più normale la condizione in cui mi trovo ora, nel senso che io sono un’italiana all’estero, laddove prima ero un’ italiana in Italia, che però non si sentiva a casa sua. Adesso, con questa distanza direi di aver trovato più la mia misura, forse per via delle modalità di vita a Parigi (che certo non sono le stesse del resto della Francia), perchè tutto sommato c’è meno sessismo e per altre componenti della vita di tutti i giorni che mi rendono globalmente più consono il vivere lì.
Però è una vita da italiana, la mia: di fatto non riesco a radicarmi, nè voglio. Non so quindi se sia un transito, se duraturo, ma certo è una presa di distanza. Continuo a seguire tutto del mio paese e, se non torno per cinquanta giorni, come ho detto, scalpito, quindi il legame d’amore è fortissimo. E’ una distanza che ho voluto, è stata una bella occasione di lavoro a portarmi via dall’Italia, ma certo io ero pronta per emigrare.
Nel tuo penultimo libro narri, a proposito del tuo esilio, del rapporto polemico con il paese che ti ospita, amato da lontano, ma verso il quale intrattieni oggi lo stesso rapporto che avevi con l’Italia da residente.
Racconti di usare la lingua madre come baluardo per le tue piccole vendette private nei confronti dei francesi e del loro idioma, della loro forzata cortesia e del loro eccesso di etichetta ai limiti del grottesco, della patologica assenza di spontaneità nei rapporti umani.
Tu dici di preferire il tuo paese di gran lunga e di considerare ogni giorno la possibilità di tornare senza però riuscire a metterla in pratica.
Scrivi che tornare significherebbe avere accettato l’idea del trascorrere del tempo, essersi pacificati col fatto che sono mutati luoghi e volti.
In realtà tu possiedi la consapevolezza profonda che a quel passato cui aneli non si possa più tornare, perché il tempo è trascorso e tornare a casa equivarrebbe a un impossibile tornare indietro nel tempo.
E’ questo il motivo per il quale il tuo desiderio di ritorno rimane solo un tentativo immaginario, finendo col trasformarsi nel suo opposto, in un desiderio di non ritorno?
In questo momento purtroppo gli argomenti per non tornare sono tanti. Trovo l’Italia allucinante in questo periodo e mi sembra che la distanza mi dia maggiore lucidità per guardare a questo degrado. Certo, se dovessi stare qui adesso, dovrei pur campare e allora, come tanti amici, pur stando male, non giudicherei con la stessa intransigente obiettività che spero di mantenere vivendo a mille chilometri.
Quindi direi che da un anno in qua, da quando il nuovo governo si è insediato, l’idea di vivere sempre in Italia io l’abbia del tutto abbandonata. A ogni modo, sempre più mi rendo conto che la radice sei tu, è il tuo corpo, è la tua esistenza quotidiana, è la casa che riesci a costruire, in affitto o di proprietà, sono i luoghi dove stai, dove consumi la tua vita quotidiana. Quando riesci ad assumere quello, puoi accettare di non avere una casa con la C maiuscola, non una patria con la P maiuscola, accettare insomma di essere una persona policentrica; qualcuno che coltiva un suo giardino per mezzo di azioni quotidiane, con cura, giorno dopo giorno. Ecco non mi vedrei qui oggi, così come non vorrei vedere in Italia in questo momento persone che amo.
Tu attribuisci valore salvifico all’invenzione. Creare salva, scrivi, permette nuovi assetti, permette di dire se stessi in un modo rinnovato, di convogliare in un racconto la rabbia che preme, il dolore che opprime.
Trasfigurare può davvero “condurre alla fine di una notte”?
Scrivere e inventare ti hanno salvata, è così?
Sono sempre molto affascinata da questo tema della trasfigurazione, cioè di come riesci a veicolare quanto vivi realmente in delle fantasie. Siamo in una fase della letteratura in cui si pone molto l’accento sull’autobiografia, una fase in cui, se non si parla di sè, sembra che non si possa dire niente. Io, invece, penso che abbiamo molto bisogno di storie anche inventate. Per quel che mi riguarda, l’invenzione è una conquista, non un punto di partenza.
Credo di essere una persona intelligente ( lo dico senza nessuna presunzione) e l’intelligenza non sempre gioca a favore dell’invenzione. Bisogna avere un rapporto molto immediato fra le proprie fantasie e il talento di scrivere e di usare le parole. Se, invece, si tende a ragionare molto, il ragionamento può essere un grande ostacolo. Quindi per me lo sforzo paradossale è il togliere pensiero, il sottrarre e alleggerire un’attività mentale che tende spesso a esagerare. In questo senso la trasfigurazione diventa felice, quando il mentale viene sorpassato da istintività e autenticità.
Ma dopo tutto questo errare tra dubbi e contraddizioni la mia sensazione è che tu, abbattendo dighe e rompendo argini, alla fine il confronto con il paterno lo abbia avuto.
Sembra, leggendoti, che tu abbia finalmente smesso di essere figlia, di dilazionare il confronto con te stessa e di scaricare le responsabilità su altri. E che abbia capito che aver trovato la tua voce è aver trovato un tuo posto nel mondo.
Bellissime le tue conclusioni, quando dici che scrivere per te è tornare a casa e che alla fine di una lunga notte hai imparato che bisogna provare ad essere dimora per se stessi e sapersi offrire rifugio, perché forse una casa a cui tornare davvero non c’è.
Possiamo allora dire in conclusione che, se pur nel precario gioco degli equilibri esistenziali mai conseguiti in via definitiva per chi, come te, pratica il dubbio di mestiere, tu nella scrittura hai trovato un tuo centro di gravità?
Sì, che sia un centro di gravità conquistato sono sicura. Penso anch’io di essermi affrancata da una storia di figlia, non tanto perchè diventata madre (evento che comunque conta molto), quanto per essere venuta a capo di rovelli e di sofferenze legate, non lo nascondo, a figure familiari da me vissute in modo problematico. Attribuivo loro una mia mancanza di determinazione nel trovare una strada. Ho quest’immagine di me bambina davanti ad altissime librerie, che guardo migliaia di titoli, so già troppe cose per la mia età e tutto è bello e interessante e possibile, che equivale anche a dire che tutto è troppo.
L’affrancamento è stato molto lungo per me, però c’è stato.
Piuttosto, quando sei adulto, il rischio è di scrivere delle cose un po’ noiose, perché l’età adulta è di per sè piuttosto noiosa. Si lavora, si è pieni di responsabilità, le giornate si spendono tra molti doveri e risulta difficile ritrovare quell’ elemento fanciullesco che la fantasia creativa richiede.
Dunque , se è vero che mi sono affrancata, non è detto che la fantasia lo stesso zampilli.
Posso dire una cosa? Nel tuo caso non credo si corrano rischi sulla noia dell’età adulta, che sicuramente si avverte in alcune giornate, perché tu l’antidoto ce l’hai scritto in volto. Il tuo è un volto di bambina, hai ancora quella freschezza e quella curiosità che corrispondono a quell’età della vita.
Anche tu (ride). Basta sfuggire a quell’alone di noia che aleggia intorno a tanti adulti…
Si, ma è intorno, appunto, non dentro di te (e qui rido io).
Grazie per essere stata con noi, Lisa, e un grazie particolare da parte mia, che, come te, cerco nella lettura suggestioni con cui entrare in risonanza e tra le tue pagine ne ho trovate tante.
Grazie a te.