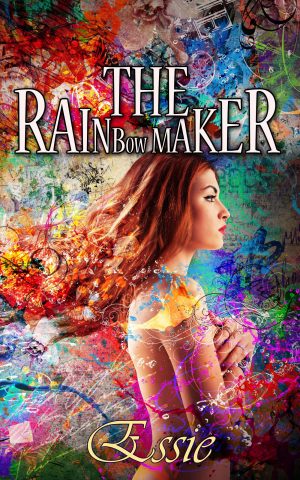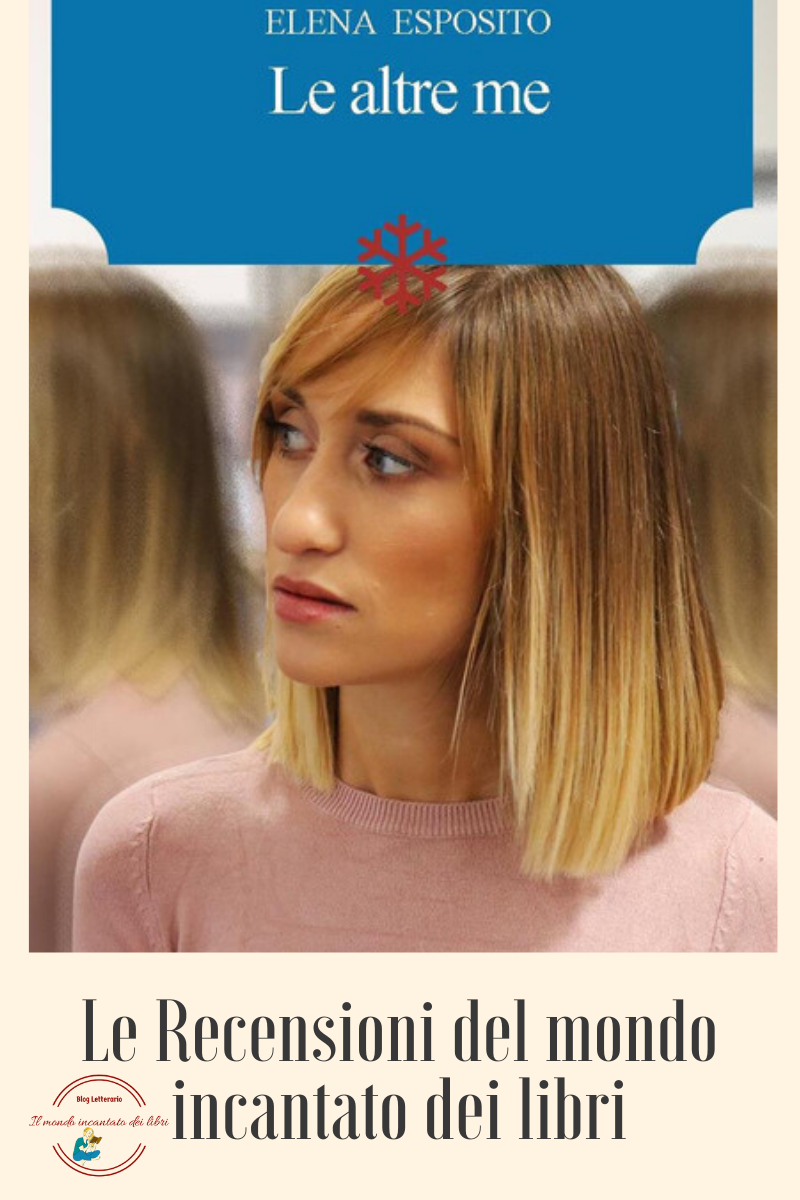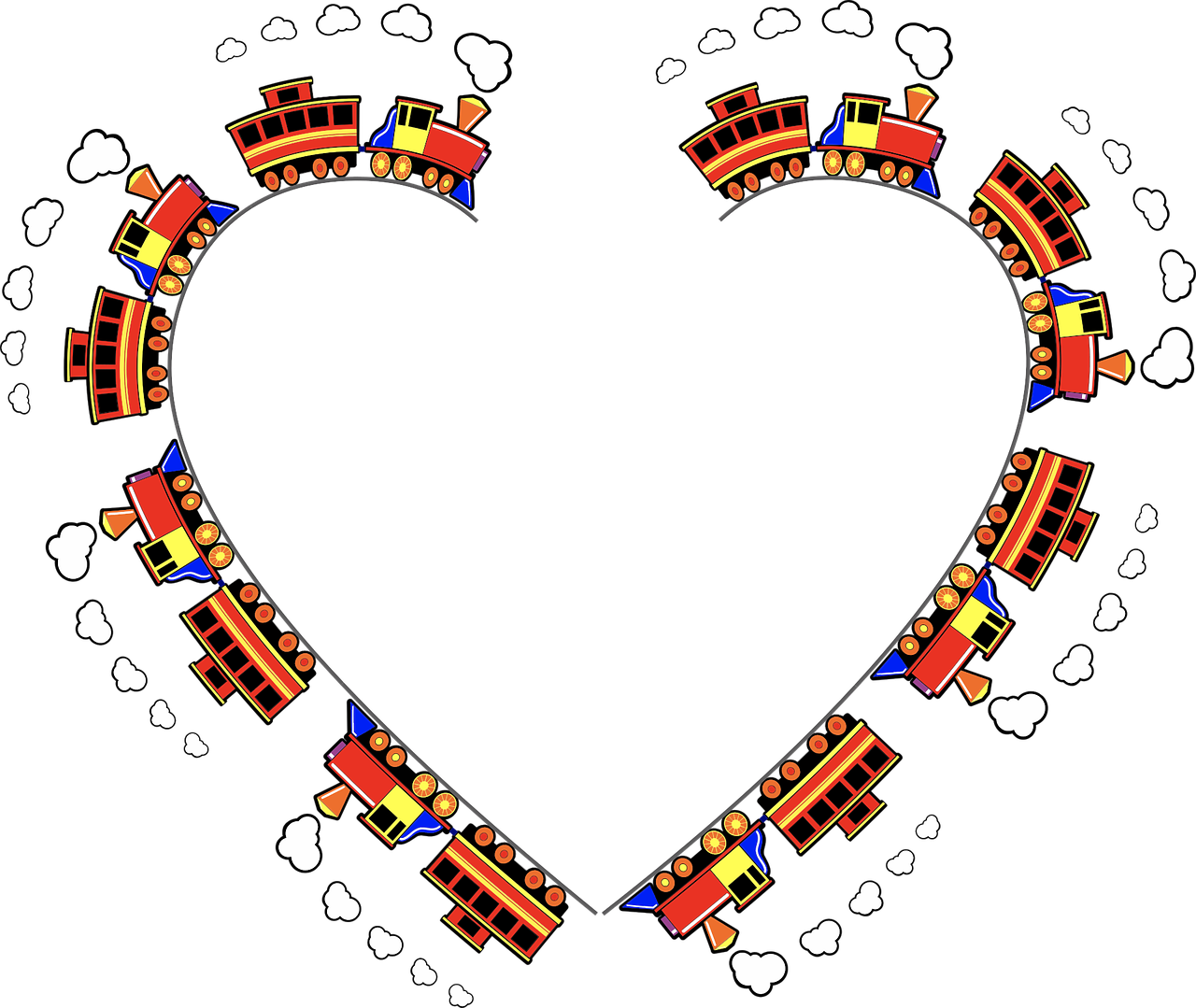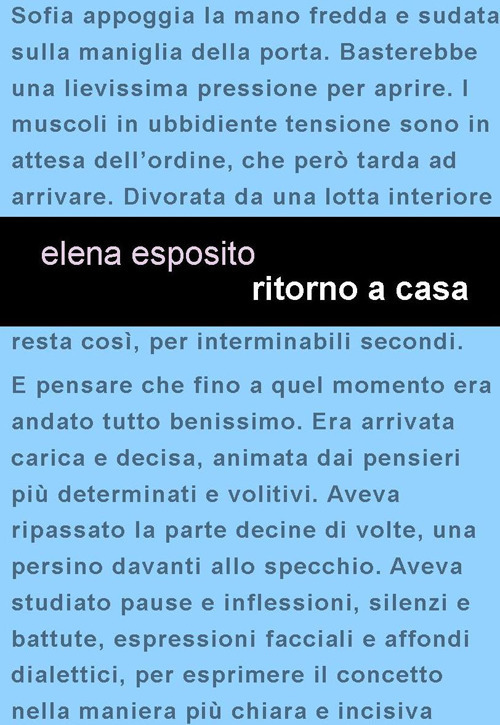Segnalazione del libro di Elena Sombre ” The rainbow maker”
Sinossi
Chetty ha un compagno di cui si è innamorata quando entrambi erano molto giovani e adesso è tanto inserito nella routine della vita a due quanto affondato tra i cuscini del divano. Lei forse ha perso il lavoro e non riuscire a capirlo è ancora più stressante di doversi rimboccare le maniche per cercarne un altro.
Vede il suo mondo sbriciolarsi, ma quando si tocca il fondo poi bisogna per forza iniziare a risalire… non può essere tutto nero. È così che inizia la sua ricerca della felicità, ogni giornata dovrà essere dominata da un colore e lei ce lo racconta come se fossimo nella sua testa in ogni istante.
Insicura e sognatrice si trova a dover fare i conti con i desideri e la realtà, una madre troppo invadente, vicine di casa strampalate, rivalità forse infondate forse no, la proposta di un amore illegale…
E poi ha un’età da febbrone, nella quale non si riconosce, e questa forse è tra tutte la sua problematica peggiore.
Sarà facile ritrovarsi nei suoi panni alla ricerca di un arcobaleno che ci piova addosso… a cuor leggero…
I Capitolo Nero
Le 22:30, è una notte d’inverno e sono seduta sotto ai neon della sala d’attesa. Dondolo da un ischio all’altro con la testa china sul petto, devo sembrare un essere allampanato, uno di quelli con gambe d’uccello e un colorito smorto, scivolato dalle pagine di qualche romanzetto fantasy fin sul pavimento sbavato.
L’aria è irrespirabile, il lezzo di animali e malattia mi stringe ancor di più la gola, ma sono già uscita almeno una decina di volte; la temperatura in questa campagna senza luci deve essere vicina allo zero. Non ho preso con me né sciarpa né quanti, mi assale un dubbio, trattengo il respiro e abbasso lo sguardo sulle mie gambe scivolando fino ai piedi: non indosso il pigiama e neppure le ciabatte, per fortuna mi sono cambiata. Un po’ di fiato mi scivola tra le labbra, dovrei sentirmi più rilassata?
Me lo chiedo e un nodo mi sale in gola.
Questa è la clinica veterinaria in cui avevo giurato non avrei più rimesso piede.
L’ultima volta ci avevo portato la mia gatta Nina, è stato quando per un semplice esame del sangue, tra le mani di questi medici l’ho vista trasformarsi in un bamboccio per riti voodoo.
Ma adesso c’è stata un’emergenza.
Il mio sguardo non mette a fuoco nessun punto: è così che mi allontano dalla realtà. Se avessi pensato prima a trovare un altro posto, adesso sarei lì dove sono più competenti, e non qui. Ma non avevo previsto che potesse accadere qualcosa di grave.
Eppure è successo.
Le cose nere accadono sempre quando non si è preparati; io mi stringo tra le spalle come una fisarmonica chiusa, forse se riuscissi a rendermi invisibile potrei farla franca; ingannare la realtà.
Strizzo le palpebre e buco il nero attorno a me immaginando una luce giallo-pilsner-tedesca che mi avvolge; è l’unico capace di tranquillizzarmi.
È il colore di casa, della mia infanzia, della vita in famiglia e delle feste a sedici anni. Anche a venti.
Anche dopo.
Da dove vengo io, una località affacciata sull’Adriatico nel nord-est, ex dominio austroungarico, frequentata da svizzeri, tedeschi, austriaci, olandesi e danesi più che da italiani, l’october fest dura da maggio ad ottobre.
Con la birra lì si fa tutto, si trascorrono le afose serate estive sulla terrazza di casa con la propria famiglia, si prendono le prime sbornie, si cucina, si prendono altre sbornie, si fanno i falò in spiaggia e ci si mangia la pizza in qualche giardinetto con il fidanzatino estivo.
È per questo che il giallo-pilsner-tedesca mi riesce a calmare.
È il colore di casa mia.
È il colore di sempre, e sapere che un “sempre” esiste riesce a farmi sentire più sicura di me stessa.
È il colore della mia infanzia, di mio padre quando aveva i baffi, i capelli ancora neri e riempiva il frigorifero di Moretti. È il colore di mia madre, quando d’estate la andavamo a prendere a lavoro e poi mangiavamo la pizza con la Warsteiner.
È il colore della Corona delle prime serate in discoteca, e della Ceres dei falò sulla spiaggia.
Ma anche il giallo-pilsner-tedesca dura poco, è subito nero. Di nuovo.
Di quelle come me è pieno il mondo, io sono quella che quando non ha bisogno di fare qualcosa, la rimanda a data da definirsi.
Io temporeggio con la vita, fino a che, prima o poi, finisco col sbatterci contro il muso.
Quindi non ho avuto alternative.
Dovevo fare in fretta, e sono venuta nell’unico posto da cui mi sarei dovuta tenere alla larga.
Le luci sul soffitto mi gocciolano addosso un’aria da epatite, e dietro di me, oltre la porta chiusa, c’è il mio coniglio.
La mia coniglia.
Insomma, c’è Celeste.
Gli occhi mi si gonfiano, se non mi calmo tracimeranno. Non mi va, prima o poi arriverà qualcuno, non voglio piangergli davanti, io ho trentotto anni, un’età da febbrone.
«Chetty?»
«Uhm? Ghghghgh uhm?»
Chetty sono io, come tanti altri ragazzi e ragazze, uomini e donne, mi porto addosso da una vita l’errore delle mode. Mi chiamo così perché a mia madre piaceva la canzone dei Pooh, “Piccola Katy”.
È chiaro a tutti che, se mio padre le avesse almeno regalato la musicassetta che lei voleva, avrebbe saputo anche come scrivere il mio nome.
Gli uomini sono tutti uguali.
Ma per me non è un problema.
Sono i segni particolari a renderci speciali.
Almeno, quando un prof. mi chiamava per interrogarmi, non mi voltavo con il cuore in gola e la speranza negli occhi, verso una mia omonima.
Nella mia classe c’erano tre Silvia, due Chiara, due Andrea. Se chiamavano Anna alzava lo sguardo impietrito anche Rosanna; ma di Chetty c’ero solo io.
Abbassavo la testa e affrontavo la realtà dei fatti.
È così che ho imparato ad affrontare le responsabilità.
Grazie al mio nome ho capito come essere concreta, senza farmi illusioni. Quando bisogna eliminare, licenziare, disfarsi di qualcuno, e dicono “Chetty”, quella sono io e basta.
Il rompicoglioni di turno mi capita spesso tra i piedi, quello che chiede spiegazioni, domande che sembrano quasi insinuare ci sia stato un errore, magari una colpa dell’ufficio anagrafe.
“Si scrive anche così, non lo sai? No? Strano…” dico allo stalker che vedo ancora davanti a me, e in qualche modo me la cavo sempre.
La gente annuisce con aria saccente, a nessuno piace fare la figura di chi ignora, e io me la rido alla grande.
Ma a volte capita l’ossessivo tenace, quello che non si rassegna, quello deciso a spalancare tutte le ante del tuo armadio finché non avrà trovato almeno uno scheletro.
«Chetty è il diminutivo di CatherineParr.» sbotto con il tono di chi non si aspetta una risposta.
Qualcuno recupera frammenti di storia inglese, gli occhi diventano vaghi, annuiscono tutti con cenni del capo non troppo convinti, la maggior parte borbotta parole come “Tudors”, “certo, come no?”, “sei mogli”. Le donne più spesso mormorano “Jonathan Rhys-Meyers”.
Solo i più veraci hanno la sfrontatezza di chiedere spiegazioni.
«L’unica donna sopravvissuta ad uno stronzo all’ottava potenza» dico tutto d’un fiato.
Di solito qui la gente ride, e poi cambia argomento, mentre il dubbio che io gli abbia con garbo dato del seccatore si insinua al punto che, difficilmente mi riceverò altre domande.
Anzi, di solito divento una di quelle da evitare.
A me piace il mio nome, e poi con un cognome italianissimo, io sono Chetty Russo, mi dà l’aria di essere un’americana almeno di terza generazione.
Potrei dare del filo da torcere perfino a Louise Veronica Ciccone e Jane Fonda.
«Chetty?»
«Ghghghgh uhm?»
Qualcuno mi chiama, il tono della voce è basso e dolce, flautato.
Mia madre non c’è e quindi, se un’estranea mi si rivolge con tanta cautela mentre un occhio del mio coniglio è schizzato quasi del tutto fuori dall’orbita, o sono davanti a una madre Teresa di Calcutta, o può solo voler dire che non ci sono buone notizie.
Alzo lo sguardo da terra e attraverso un muro d’acqua salata più del Mar Morto, prima di riuscire a distingue la sagoma della dottoressa.
«Ghghghg?»
Samantha mi guarda con un sorriso che mi fa sentire storpia, o deve almeno essermi comparsa qualche grave malformazione tutta d’un tratto.
Controllo il respiro, sento la schiena irrigidirsi e non posso evitare che la stessa sensazione dilaghi fino ai muscoli del viso, mentre un’onda di rabbia sta spazzando via anche la voglia di piangere.
Rimangono solo mille dubbi ad accalcarsi nella mia testa, senza freni, come teenager indiavolate al concerto di Justin Bieber.
Uno rintrona coprendo tutti gli altri: quando la dottoressa mi ha confidato il suo terribile progetto, spingere dentro l’occhio senza indagare il motivo di ciò che lo sta facendo uscire, perché non ho afferrato il trasportino e non sono scappata?
Eppure scappare è la mia specialità.
Davanti alle difficoltà, davanti all’inaffrontabile, io scappo sempre.
Sento una forza improvvisa invadermi con la stessa prepotenza della rabbia che ancora non mi ha abbandonata, e il mio mento scatta verso l’alto.
I nostri sguardi si incrociano, lei mi guarda ancora con quel suo sguardo da Monna Lisa, io le incollo gli occhi addosso.
I medical drama americani hanno lanciato la moda di indossare un completo di cotone che sembra un pigiama, anche lei ne ha uno.
Tutti ormai ne hanno uno. Però il suo è macchiato da tanti piccoli puntini che prima non c’erano.
Prima era solo ciclamino e affollato da gattini e cagnolini sorridenti e scodinzolanti.
Nonostante il suo abbigliamento da Dottor clown non mi suscita nessun sorriso, per me lei è nera come la notte.
Deve pensare che non riesca a reagire, perché mi chiama di nuovo. Alzo le sopracciglia sperando che così si sollevino di più anche le palpebre e mormoro un «Si?» che inaspettatamente sibila come il rumore della corrente quando c’è una dispersione.
Come quando un filo elettrico è rosicchiato ma non tranciato.
Io lo conosco bene questo suono, in casa mia non c’è un cavo che si sia salvato dal passaggio di Celeste: li ha assaggiati tutti.
Dove potevamo li abbiamo fatti passare dentro ai rivestimenti protettivi, ma non ci si riesce sempre. Non lo si può fare al cavo dell’aspirapolvere, e anche quello a casa mia ha il segno dei suoi denti, come le mie ciabatte da giardino, il foulard copridivano, la tracolla della borsa, e un centinaio di altri oggetti.
In pochi secondi riusciva a farmi perdere le staffe, e a farmi sentire in colpa se non mi fossi scusata all’istante.
In quel momento diventava Celestina-amore-mio-perdonami.
La dottoressa è ancora davanti a me, se non parla allora vuol dire che sta assemblando una frase che non vorrebbe dover dire. Spero che sia solo una rimbambita incapace di fare lo spelling, eppure ho la sensazione che stia temporeggiando.
Un atteggiamento che io conosco fin troppo bene.
Brancola nel buio.
Sembra me quando cerco di decifrare il foglio di istruzioni per montare un mobile dell’Ikea.
Spero che non sia quello che penso, e sono felice di vedere tutto attraverso una gran quantità di acqua.
Ha i capelli arruffati e uno sguardo che, se va d’accordo con la tristezza della sua voce, sono fortunata a non cogliere nei particolari; sott’acqua c’è meno luce.
«La situazione è grave» mi dice, e io non vedo più niente.
Mi inabisso di metri e metri.
Mi parla lentamente, scandendo ogni sillaba.
Mi chiedo come faccia già a considerarmi un’idiota.
Eppure non ci siamo scambiate che qualche parola, in questa clinica lavorano troppi medici perché si possa ricordare di tutte le altre volte in cui ci siamo incrociate: lei di fretta mentre entrava in un ambulatorio e usciva da un altro, io seduta con il gatto di turno nel trasportino tra i piedi.
Poi mi viene in mente che deve aver letto il mio nome sul libretto medico di Celeste.
Si, deve pensare che una “Chetty Russo” deve per forza essere un’americana.
La mia pronuncia disperata, con il dolore nel cuore sembra che ho una patata in bocca, gliene avrà dato la conferma.
Forse una traccia di tutti gli anni trascorsi in Inghilterra, come una vagabonda pur di stare lontana da casa e sentirmi un’adulta indipendente, deve essere evidente nel mio sguardo almeno quanto le lentiggini sulla faccia very English di Eddie Redmayne.
Tra me e me parlo ancora come una ragazzina, perché è così che mi sento: una quindicenne con tante più cose da raccontare di una quindicenne.
Quando quindici anni li avevo davvero, guardavo le donne più grandi, quelle di trent’anni, e mi domandavo quand’è che la trasformazione si attui.
Ci deve essere un momento in cui, inconsapevolmente, qualcosa cambia, come accade per le farfalle, perché la maturità di certe ragazze trasformate in donne traspira da ogni poro della loro pelle. La avverto nei movimenti della camminata, la scorgo negli sguardi e perfino la tecnica di leccare il gelato cambia.
Non c’è niente da fare, a volte guardo delle donne capaci di portare talmente bene la loro età, che le invidio e non vedo l’ora di arrivarci pure io.
E poi mi accorgo che io, quell’età, l’ho addirittura superata.
Io ne ho trentotto, come una febbre che ti lascia distesa a letto a suon di legnate in testa.
Ma continuo a sentirmi la leggerezza dei miei quindici anni, e non è giusto che una quindicenne soffra così.
Io sono una di quelle persone che preferisce fare finta non sia mai accaduto nulla, scrollo le spalle e riparto con un nuovo inizio.
Guido per le strade deserte e buie mentre sembra che fuori diluvi, ma gli unici tergicristalli che devo azionare sono le mie mani da un occhio all’altro.
Sul sedile accanto a me c’è il trasportino rosa, e dentro la mia Celeste.
I conigli sono delicati, lo dicono tutto, ma il dolore che provo è feroce.
Non sono una vera quindicenne perché dico certe parolacce, che una ragazzina, se le dicesse, si vedrebbe sbriciolare anche l’anima dai genitori.
Però a mia giustificazione le dico solo tra me e me. Certe espressioni, quando escono dalla bocca di un uomo, sono solo frasi colorite.
Un arcobaleno di irriverenze.
Fuori dalla bocca di una donna invece perdono colore e puzzano di bile.
Per questo motivo almeno da più di dieci anni ho il buon senso, se proprio qualcosa mi scappa a voce alta, di dirlo in russo: così nessuno capisce.
Di solito dico блядь, che suona più o meno come una smorfia disgustata… bljad’.
E invece ho detto qualcosa che significa meretrice, ma che farebbe impallidire anche Ivan Drago.
Telefono a Davide, mio marito.
Lui adesso è in Sicilia, sta lavorando lì e ne avrà ancora per una settimana. Guardo l’ora, le 23:30, dovrebbe essere nella sua stanza d’albergo. La strada è sempre deserta e il telefono squilla, poi tace.
Bljad’!
Abbasso le spalle mentre con le dita arpiono il volante, sono da sola e non ho bisogno di nascondere il senso di abbandono in cui sto sprofondando. Per risollevarmi scarico uno scroscio di espressioni colorite e giro lo sguardo verso il trasportino.
Non avrei dovuto farlo.
Siamo sole, io e lei.
E io da sola ci sto bene, anche se ogni tanto mi piace la compagnia e spesso attraverso certi momenti in cui, se non avessi Davide a sorreggermi, cadrei.
Forse sono perfino felice che non mi abbia risposto, così non devo dire quelle due parole: è morta.
E se non le dico mi posso ancora illudere che non sia accaduto.
Poi penso che sarò da sola anche a scavare la buca, la terra ghiacciata dell’inverno è maledettamente dura, a casa non ho più neppure mezzo sacco di calce viva.
Inanello un pensiero dietro l’altro fino a infilare il peggiore: devo darmi una mossa e avvolgerla prima possibile in un lenzuolo – dopo tre ore i morti iniziano ad irrigidirsi.
È Deborah a dirmelo. Io non ci avevo pensato.
Lei è la fata madrina di Celeste, l’ha allattata quando è stata recuperata, e cresciuta finché non è diventata la peste che io e Davide abbiamo adottato. L’ho chiamata perché da sola, in questo momento, non ce la faccio proprio a stare, e anche se è tardi, lei mi risponde al secondo squillo.
«Non ho mai toccato un animale morto, qualcun altro ha sempre fatto il lavoro sporco per me. » mi si forma una bolla in gola, forse la tiroide mi sta per scoppiare.
«Pensa a tutte le volte che l’hai tenuta in braccio» dice Deborah per darmi coraggio, «È sempre lei, non mi puoi dire che non ci riesci».
Si sbaglia, non è sempre lei.
Questo è un pupazzo che non sta più in forma, con gli occhi sbarrati, uno sguardo fuori dal bulbo oculare e la linguetta di traverso. Storta.
Alla fine lo faccio, solo perché sono costretta, mentre mi sento terribilmente in colpa per i miei occhi chiusi e la testa girata.
Ingoiare, respirare, parlare, andare avanti, è tutto maledettamente difficile.
Solo il fiume salato che mi trabocca dalle ciglia è maledettamente facile.
2
PIOMBO
«Cominciamo!»
Il gran respiro preso appena un attimo prima, non è servito a tenere in equilibrio la mia voce: si è rotta neppure a metà parola. Stringo le dita attorno al manico della pala fino a farmi sbiancare le nocche, dicono che quando si tocca il fondo poi si deve per forza risalire.
Non sono mica un sasso, penso, e aspetto di sentire il momento in cui mi staccherò dal fondo dell’abisso. So già che il dolore durerà per un bel pezzo, ma almeno non sono da sola a seppellire Celeste; la buca, quella sì ero da sola a scavarla.
Ma poco importa.
C’è il dolore che va pianto in solitudine, e quello in cui si ha bisogno di una persona vicina.
Per il primo ci sono già passata, adesso sono decisamente in fase due: ho già quasi terminato i mille minuti di traffico voce mensili della mia tariffa telefonica, e con me c’è Emma, la mia vicina di casa.
Ecco, i vicini servono anche a questo, a spolverare i colori.
Così il mio nero #000000 è aggredito dalla luce come un virus dai globuli bianchi, e adesso sembra un paio di vecchi jeans neri che hanno fatto troppi giri in lavatrice.
Nessuno sarebbe salito in macchina per venire a seppellire la mia coniglia, ma lei adesso è qui con me. E non importa se lo sta facendo solo perché abita nella casa accanto alla mia.
Quello che conta è che lei è qui, e io non sono da sola.
Emma impugna la pala esattamente come me, ricopriamo la mia “Orecchie Lunghe” una volta a testa, affondiamo nel fango fino alle caviglie, e non ho ancora terminato di guardare il mondo con uno sguardo acquoso.
La casa è silenziosa in maniera irritante.
Senza Celeste c’è una mancanza di suono che mi frastorna, eppure mi restano sempre sei gatti e un altro coniglio.
È la mia voce quella che manca.
«Celeste smettila!»
«Cosa stai facendo?»
«Celeste! In lettiera!»
«Celeste vuoi?»
«Di chi è questa pipì?»
«Celeste dai vieni sul divano, solo tu mi puoi capire.»
E senza di lei non c’è più nulla di celeste. Il cielo è un ammasso cotonato fumo di Londra, il sole è sparito da giorni sia in casa che fuori, ma in casa un po’ di più.
Tutto è opaco.
In questi giorni sto correggendo il mio libro, quello che dovrei pubblicare. Un romanzo.
Sono al capitolo del giorno di Natale, e io non mi sento solo triste come chi ha subito un lutto.
Sono disperata come a chi è morto qualcuno in un giorno di festa.
Natale non sarà più Natale.
Chiudo tutti i documenti aperti nel mio pc, non ce la faccio. Ho un vuoto dentro che mi divora a piccoli morsi.
Mi sembra di aver letto un romanzo lunghissimo, scritto tanto in piccolo da riuscire a starci tutto dietro al prologo. Adesso è finito, giro pagina, e una storia nuova inizia mentre quella vecchia non è lontana, è proprio sotto al foglio di carta che tengo ancora tra le dita per un angolo. Eppure non la posso più avere, perché questo è il libro della vita, e una volta voltata pagina, non è più possibile tornare in dietro.
La nuova storia è inchiostro nero su un foglio bianco; anche se non li vedo tra le mie mani ci sono tutti i colori. Dipende da me come usarli.
Certo me ne manca uno e dovrò fare a meno del celeste.
Forse se un giorno capirò come raggirare il dolore e vivere solo eventi felici, magari ritroverò anche quella sfumatura che adesso mi manca.
Credo che se riuscissi ad avere tutti i colori, li potrei usare per essere più felice.
Fluttuo dal letto al divano con un’espressione spenta e abbracciando sacchetti di cibo-spazzatura, ma chi è quell’idiota ostinato ad insistere su quanto tutto ciò che si trova in tubo, pacchetto o buste faccia male?
Se non esistesse la cioccolata, sarei seriamente costretta a prendere in considerazione l’eventualità di rivolgermi ad un terapeuta.
Accartoccio il sacchetto vuoto di patatine e lancio uno sguardo tutto attorno al campo di battaglia; dovrei alzarmi, darmi da fare, scopare le briciole a terra e ripiegare la copertina sul divano come se non servisse più.
Mi sento già meglio, adesso ho un piccolo planning di buoni propositi da mettere in atto: domani avrò degli obiettivi da raggiungere.
Domani.
Oggi voglio scivolare ancora un po’ in tutte queste sfumature di grigio, sono in lutto, capiate il mio dolore.
Non ci resta che acquistarlo e leggerlo.. buona lettura a tutti.