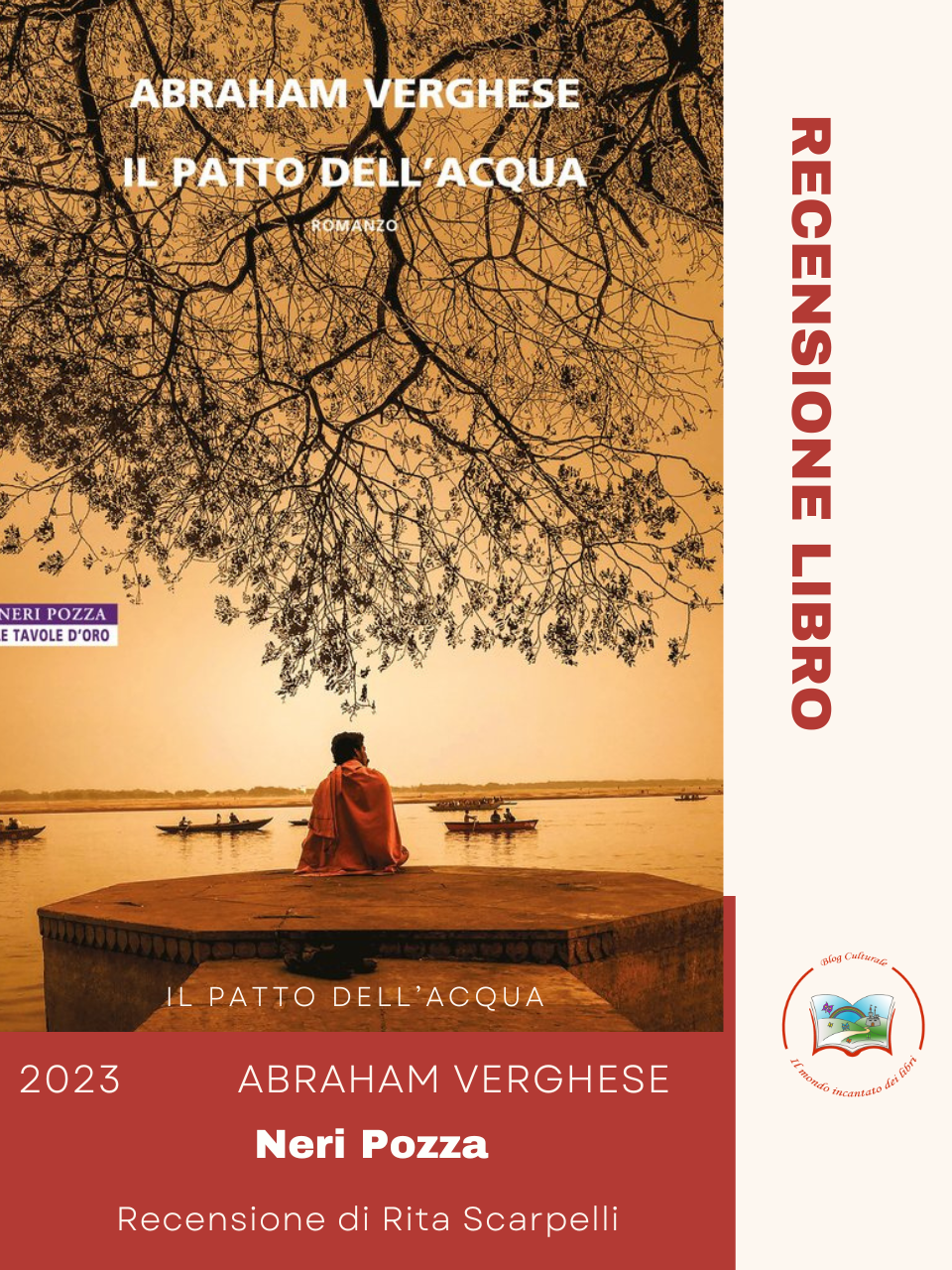
Il patto dell’acqua, Abraham Verghese. Neri Pozza editore.
“We are all in the gutter, but some of us
are looking at the stars”
(Siamo tutti nati nel fango, ma alcuni di noi guardano alle stelle)
Oscar Wilde
Ci sono dei periodi della vita duranti i quali si ha bisogno di lasciarsi avvincere da storie imponenti sia per la consistenza dei personaggi che per quella delle pagine, storie che ci fanno viaggiare per giorni e giorni e che ci raccontano, attimo dopo attimo, le vicende di esseri umani, eroi per caso, nelle pieghe della loro vita.
In base alla mia esperienza pluriennale di lettrice solo alcuni autori sono stati capaci di regalarci questo tipo di romanzi, mantenendo costante il ritmo narrativo per l’intera durata dell’opera: mi vengono in mente Isabel Allende, Gabriel Garcia Marchez, Massimo Valerio Manfredi, Oriana Fallaci, Marcel Proust, Lev Tostoj e pochi altri.
Ecco perché quando il mio libraio di fiducia mi ha proposto “Il Patto dell’acqua” sono stata inizialmente alquanto diffidente: una storia di circa 850 pagine, che attraversa diversi decenni partendo dal 1900, ambientata in India e scritta da un medico etiope si sarebbe potuta rivelare una combinazione eccessivamente eterogenea e forse addirittura noiosa.
Eppure…ho deciso di correre il rischio ed acquistarlo: negli occhi del libraio un guizzo di approvazione, presumibilmente non solo dovuto alla vendita di un ulteriore volume ma anche alla scelta fatta.
E’ stata una decisione felice, perché ho letto un romanzo davvero notevole sotto molteplici aspetti, a partire dalla trama, incredibilmente originale: la narrazione è ambientata in India nel Travancore, Costa del Malabar, dove una ragazzina di appena dodici anni percorre un lungo viaggio verso il Kerala, per recarsi a sposare un vedovo di trent’anni, già padre di un bambino.
«Il giorno più brutto nella vita di una ragazza è il giorno del matrimonio. Poi, se Dio vuole, le cose migliorano»
E’ la frase di rito che viene detta alle spose bambine che passano da un padrone, il padre, ad un altro padrone, il marito: in questo caso il prescelto dal sensale dei matrimoni è alquanto benestante e condivide con la sposa bambina, Mariamma, l’appartenenza ai Cristiani di San Tommaso, una Comunità convertita diciotto secoli prima.
La ragazzina viene accolta con sorprendente calore dai nuovi parenti e rispetto dallo sposo, che ne accompagna con delicatezza la crescita fino a farla innamorare di lui, consentendole di diventare adulta senza traumi e di integrarsi nel nuovo habitat; un contesto, però, che è avvolto in uno strano mistero: una maledizione colpisce da generazioni la famiglia dello sposo, un’avversione letale all’acqua, che, per alcuni membri, si conclude con la morte per affogamento.
Ma, per uno strano scherzo del destino, in Kerala l’acqua è ovunque, è l’humus della vita, attraverso una varietà infinita di laghi e lagune.
Ciò nonostante Mariamma diventerà Grande Ammachi, grande mamma, e guiderà la sua famiglia per tre generazioni, artefice e custode del focolare familiare ma anche dell’avvento a Parambil, dove risiede la famiglia allargata di cui lei è matriarca, del progresso e della modernizzazione dei costumi, fino alla realizzazione di due obiettivi che potrebbero rappresentare simbolicamente il sogno collettivo delle donne indiane: la laurea della nipote, il cui nome è ancora Mariamma, in Medicina, e la costruzione di un ospedale che consenta la cura della popolazione, e soprattutto delle donne, in modo più veloce e più equo.
Fra l’arrivo della giovane sposa Mariamma nel 1900 e quello della realizzazione professionale della giovane dottoressa Mariamma nel 1970, intercorre una vera e propria epopea umana, politica e sociale di un popolo, quello indiano, la cui cultura ci è ancora, per molti aspetti fascinosamente oscura.
Accanto alla trama affascinante nella sua originalità, si rimane rapiti dalle rappresentazioni dei luoghi, descritti minuziosamente ma con grande poesia, quasi come si fosse dinnanzi a un quadro piuttosto che alle parole: la magia intrinseca di un territorio dove terra e acqua sono un unico elemento, un unico polmone attraverso il quale l’India respira.
“In questa terra palme e borassi sono così abbondanti che, di notte, le loro sagome increspate ondeggiano e luccicano all’interno delle palpebre chiuse. Sogni beneauguranti devono contenere fronde verdi e acqua; la loro assenza determina un incubo. Quando i malayali dicono «terra» includono l’acqua, perché non ha senso separarle, come non ha senso separare il naso dalla bocca. Su barche a remi, piroghe, chiatte e traghetti, i malayali e i loro beni navigano per tutto il Travancore, il Cochin e il Malabar con una agilità che chi non vive sull’acqua fatica”.
La stessa poeticità traspare dalle narrazioni delle vicende mediche, fra cui due, la lebbra e il cosiddetto “morbo” sono veri e propri leitmotiv della storia tutta: ogni parola dedicata alla malattia fisica, ma anche psichica, è pervasa da una profonda empatia e senso del valore della cura, evidentemente frutto dell’approccio alla sua professione dell’autore, il medico Abraham Verghes.
Illuminanti sono le sue parole: “Si può essere guariti anche quando non c’è cura, con questo intendo venire a patti con la malattia, trovare un certo livello di pace e accettazione in un ambiente così terribile; questo è qualcosa che un medico può, se è fortunato, aiutare a facilitare.”
Eppure, se qualcuno mi chiedesse quale è stato il dono più grande di questo romanzo risponderei: il suo costante inneggiare alla speranza, una speranza permeata di solidarietà e di giustizia, valori che nella nostra epoca sembrano ahimè desueti.
Perfino un morbo che ha le caratteristiche di un mistero più che di una patologia può diventare una malattia da curare, soprattutto se più menti si mettono all’opera insieme.
E, soprattutto, perfino un’umanità dolente e vessata dalle vicissitudini, in una terra complessa come l’India, può trovare la strada per la rinascita, se una donna saggia di un territorio circondato dall’acqua intuisce che è solo attraverso il progresso, oltre che l’amore, che un popolo può camminare speditamente verso un futuro migliore.
Travancore, Costa di Malabar, 1900. Una ragazzina di dodici anni cerca di prendere sonno tra le braccia di sua madre. Domani lascerà la casa in cui è cresciuta per andare sposa all’uomo cui è stata promessa. Colui che diventerà suo marito, il nuovo padrone della sua vita, ha trent’anni di piú, è vedovo, con un figlio ancora bambino. La piccola sposa va incontro al suo futuro cosí come è stato deciso da altri, come hanno fatto sua madre e la madre di sua madre prima di lei. «Il giorno piú brutto nella vita di una ragazza è il giorno del matrimonio. Poi, se Dio vuole, le cose migliorano» le viene detto. Il vedovo è un buon partito, come loro è parte di quell’antichissima comunità di cristiani convertiti da san Tommaso diciotto secoli prima, e per qualche strano motivo accetta una moglie senza una rupia di dote, anche se si mormora che la sua stirpe sia afflitta da una strana maledizione: in ogni generazione almeno una persona muore affogata. E in quello che oggi si chiama Kerala l’acqua è ovunque, plasma la terra in una trina di laghi e lagune, accompagna col suo canto sommesso le esistenze, si nutre dei monsoni, collega tutto nel tempo e nello spazio. La sposa viene accolta con affetto nella nuova casa e, nell’arco della sua lunga, straordinaria vita, conosce la gioia di un grande amore, patisce il dolore di infinite perdite, assiste a cambiamenti epocali. La sua famiglia si espanderà e si ritirerà con le nascite e le morti. Finché arriverà una nipote che porterà il suo nome, studierà medicina e giungerà a una scoperta sconvolgente. Evocazione luminosa di un’India in cammino verso la sua trasformazione politica e culturale, celebrazione di un popolo antico immerso in una natura ancora prepotente, Il patto dell’acqua è il nuovo romanzo di Abraham Verghese, «che espone il lettore a una bellezza cui altrimenti non potrebbe accedere» (The New York Times); un libro-mondo di straordinaria potenza che custodisce tutti gli eventi preziosi dell’esperienza umana.
Abraham Verghese, dopo il diploma allo Iowa Writers’ Workshop, nel 1994, ha scritto My Own Country, finalista al NBC Award, e The Tennis Partner, un New York Times Notable Book. Il suo romanzo La porta delle lacrime (Mondadori 2009), ha passato 107 settimana in classifica, e ha venduto oltre 1,5 milioni di copie. Verghese ha ricevuto la National Humanities Medal, cinque lauree honoris causa ed è membro della National Academy of Medicine e dell’American Academy of Arts & Sciences. È professore e vicepresidente del Dipartimento di Medicina presso la Stanford University School of Medicine. Vive a Stanford, California.
Traduzione di Luigi Maria Sponzilli
2023, pp. 736, € 22,00
ISBN: 9788854527331
Collana: Le Tavole d’Oro
Generi: Letteratura contemporanea, Narrativa straniera
Nella pagina sono presenti link di affiliazione su cui si ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.






